Quando Benjamin Lacombe e Marco Mazzoni si incontrano, il risultato non è una semplice collaborazione artistica, ma una vera fusione di mondi. Due universi estetici diversi che, nel momento in cui si sfiorano, generano qualcosa che non può essere spiegato: può solo essere vissuto.
Il loro ultimo lavoro, “Le Streghe di Venezia”, è la prova tangibile di questa alchimia. Non è un libro da leggere o da osservare: è un’opera da attraversare. Parole e immagini si intrecciano in un racconto oscuro e delicato, dove magia, storia e denuncia sociale convivono in perfetto equilibrio. Nulla è lasciato al caso: ogni tratto a matita, ogni scelta tipografica, ogni pianta velenosa sussurra un messaggio nascosto. I due artisti ci conducono così in un viaggio che parla di libertà, metamorfosi e resistenza, tra le ombre dell’Italia dimenticata, figure femminili cancellate dalla Storia e isole intrise di mistero.
Ciò che unisce i due artisti, più delle parole, è una visione comune: quella di un’arte che non addolcisce, ma scava. Che non consola, ma trasforma. Lacombe porta la meraviglia, lo stupore del fantastico; Mazzoni la profondità, le emozioni forte come motore creativo. Eppure si ritrovano, sempre, in quell’ossessione condivisa per ciò che resta invisibile agli occhi, ma non al cuore. Come ogni vero incantesimo, anche questo nasce da due mani che si cercano, si impegnano al massimo e, alla fine, si riconoscono.
Com’è stato lavorare a quel libro da un punto di vista linguistico?
B: Parlavamo in inglese, ma io sto cercando di imparare l’italiano e lui sta cercando di imparare il francese. Ed è divertente, in entrambi i casi (ride).
E come sta andando finora?
B: Non benissimo, ma il libro invece sta andando bene (ride).
Adoro i toni cupi e le ispirazioni dietro Papillon Noir. Da dove è nata l’ispirazione e qual è stato il processo per dare vita a questo progetto?
B: Il nome della collezione ha due origini significative. Primo, la farfalla è un simbolo ricorrente sia nel mio lavoro che nella mia vita, rappresenta la metamorfosi e la trasformazione. È l’emblema perfetto del cambiamento e dell’evoluzione. Tuttavia, la farfalla nera ha un significato più profondo. Si riferisce a una specifica specie di farfalla che in origine era bianca e viveva tra alberi dalla corteccia chiara, dove il suo colore le forniva un naturale camuffamento. A causa dell’industrializzazione e dell’inquinamento, questi alberi si sono gradualmente scuriti, e le farfalle si sono adattate evolvendo una colorazione più scura per mantenere la protezione dai predatori. Questa risposta evolutiva mi ha affascinato perché dimostra la resilienza della natura, ma allo stesso tempo mette in luce questioni ecologiche urgenti. Tutti questi elementi sono confluiti poi nel logo di Papillon Noir.


Parlando de “Le Streghe di Venezia”, ho amato come le immagini fossero una parte fondamentale della storia: parole e immagini erano essenziali per raccontare la stessa vicenda, seppure in modi diversi. Com’è nata la collaborazione dietro questo libro?
B: Sébastien Perez e Marco hanno lavorato molto a stretto contatto, in un dialogo e scambio costante durante tutto il processo creativo. Insieme hanno costruito un’esperienza di lettura che diventa impossibile da comprendere senza entrambi gli elementi. Se leggi solo il testo, non capisci niente; se guardi solo le immagini, non capisci niente. Ma se vivi entrambe le componenti insieme, tutto diventa chiaro e intenso. Anche il libro, come oggetto, racconta una storia usando diversi tipi di carta e tecniche narrative che cambiano per potenziare l’esperienza.
M: Quello che ci ha fatto fare il lavoro molto bene è stato il fatto che sono due cose che non si muovono mai pedissequamente, cioè il testo non era per l’immagine e l’immagine non era per il testo, ma era tutto un mondo interno. Questo mi ha lasciato anche la libertà totale di immaginarmi quello che c’era attorno al testo e penso che questo sia utile, perché quando uno legge un fumetto, ad esempio, il disegno serve per accompagnare; invece, qui è la composizione totale di un mondo.
Vengo da una città vicino a Venezia e sono molto incuriosita dalla storia di Poveglia e da come sia un luogo di storie e leggende, oltre al fatto che l’accesso all’isola è proibito al pubblico. Com’è stato immergersi nella storia di questo luogo e nel fenomeno della stregoneria in Italia?
M: Tutto il mio lavoro artistico nasce dalla storia dell’Italia: prima del ‘700, era una nazione estremamente matriarcale, poi per vari motivi c’è stato un cambiamento ed è diventata una società molto patriarcale. Precedentemente però le donne ricoprivano, soprattutto nei piccoli paesi, sia la figura del sindaco, che del dottore che dello psicologo ad esempio. Ed è tutta una narrazione che abbiamo perso, perché non c’è racconto su queste cose se non in alcuni racconti popolari. C’è stato un grosso cambiamento a livello di linguaggio, perché prima queste donne erano delle curatrici e poi sono diventate delle streghe, pur essendo la stessa figura. Tutto il mio lavoro è sempre stato concentrato su questa tipologia di figura che comunque fa parte delle nostre radici. Poveglia invece ha una storia non solo mistica ma proprio di fantasmi. Quindi il mistero e l’occulto sembravano il punto ideale per far nascere tutta la situazione: ho inserito alcune simbologie tipiche delle mistiche all’interno del libro perché ho messo tutte le piante che usavano le curatrici, tipo la belladonna, per aiutare le donne che erano vittime di violenza domestica ad avvelenare pian piano i mariti; quindi, ho inserito tutto questo sottotesto simbolico di vendetta necessaria.
Descrivereste il libro come una fiaba moderna? A volte, quando si usa la parola “fiaba”, si pensa a qualcosa di vecchio o infantile, ma i temi di questo libro sono per tutti…
B: Io non l’ho concepito come una fiaba. Quando crei un oggetto artistico, ci metti dentro ciò che vuoi comunicare, e poi il pubblico lo riceve e lo fa suo. Per me è una narrazione per adulti, una sorta di graphic novel, nel senso che non può essere letta senza la componente grafica. È più di una fiaba; è un riflesso del nostro tempo. Quello che trovo molto interessante è come riesca a evocare problemi senza nominarli direttamente. Questo è qualcosa su cui si basa tutta la collezione Papillon Noir.


La storia riguarda passato, presente e futuro (anche se distopico), unendo realismo e fantasia. Cosa vi ha insegnato questo lavoro sulla nostra realtà e sul bisogno di “evadere”, ad esempio grazie all’arte o ai libri?
M: Sébastien ha creato un testo in cui non esiste il bene o il male, sono tutte reazioni che possono sembrare o negative o positive a seconda del momento e infatti a seconda della linea temporale, la gente che sembra cattiva diventa buona, com’è nella realtà dei fatti. Soprattutto penso che nelle opere ci sia sempre bisogno di un messaggio sociale, che sia di sottofondo o diretto. E anche nei lavori di evasione, in fondo c’è il messaggio sociale, perché è il kink che serve all’autore per spingere di più e fare qualcosa di più potente. L’evasione propria non esiste, ci deve sempre essere qualcosa che giustifichi la comunicazione.
B: Io non sono d’accordo (ride). L’ho vissuto molto durante il COVID-19, perché all’inizio della pandemia era un momento in cui nessuno sapeva cosa stesse succedendo, dove stavamo andando, o se le persone che amavamo sarebbero sopravvissute. In quel momento d’incertezza, la mia reazione è stata creare. Non avevo mai scritto o realizzato così tanti libri come allora. Mi rifugiavo nella finzione e fuggivo dalla realtà. Riflettere su ciò che stava accadendo era essenziale. Oggi con il flusso continuo di notizie non abbiamo tempo di pensare. Siamo costantemente attaccati alla realtà senza pause. Credo che la finzione, l’arte, i libri siano un modo per apprezzare meglio la realtà e rifletterci, dialogare con essa. È un modo potente per comprendere il mondo. Molti pensano che la cultura sia qualcosa di non essenziale, ma il COVID-19 ci ha dimostrato, con tutto il trauma vissuto, quanto sia invece essenziale. Questo è ciò che resta. Cosa conosciamo del Paleolitico? L’arte. Cosa sappiamo degli Inca? L’arte.
C’è una frase sulla libertà, su come sia stata tolta alla strega e su come lei abbia sempre vissuto per cercare di riaverla. Cosa significa per voi la libertà?
B: È una risposta che cambia continuamente. Ogni libertà dovrebbe essere completa, perché non puoi permettere a qualcuno di pensare in un solo modo. Bisogna avere regole e strumenti per vivere insieme, perché siamo una società, è impossibile vivere totalmente liberi. Ma la libertà di parola, di amare… dev’essere totale. Su questo non si può negoziare.
Pensando al vostro lavoro, sono affascinata dalla meraviglia che riuscite sempre a trasmettere attraverso l’arte e le storie. È difficile trovare sempre questa meraviglia, questa “magia”, questa sorpresa? O è qualcosa che vi portate sempre dietro?
B: La meraviglia è ovunque; bisogna solo imparare a vederla. Nella nostra società, ogni giorno ci sono attimi di meraviglia, a partire dalla natura. Stavo guardando un documentario l’altro giorno sulle forme perfette in natura e su come si ripetano ovunque, e su quanto Leonardo da Vinci l’avesse capito. È come se ci fosse magia ovunque. Credo che il modo migliore per far sentire davvero una storia alle persone sia usare elementi completamente diversi dalla loro esperienza, come gli elementi fantastici.


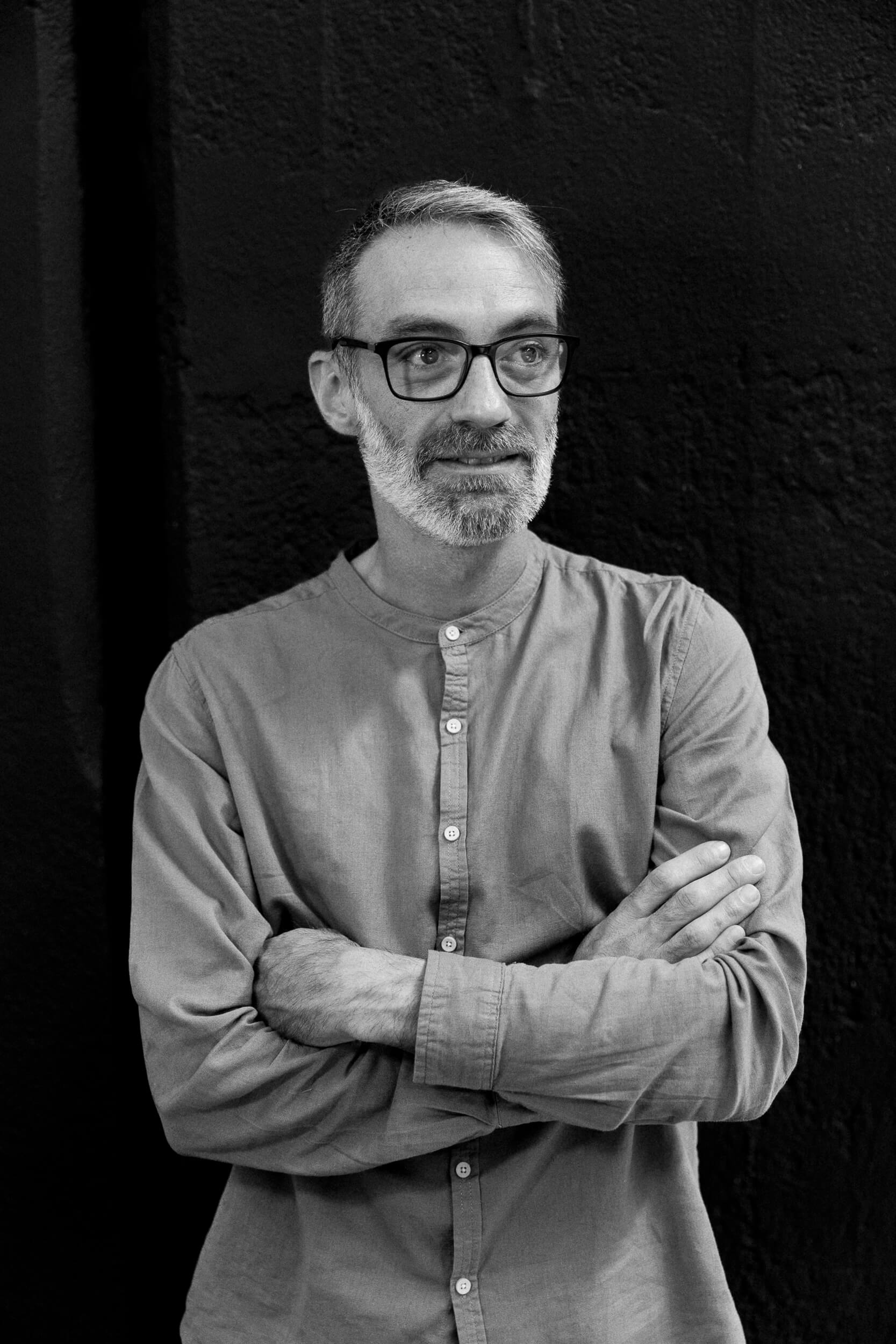
Mi viene in mente la canzone di Alice nel Paese delle Meraviglie, “In a world of my own”, quando penso a te. Di cosa è fatto il tuo mondo?
B: Spero di tante cose. Non è un mondo molto meccanico, è molto organico (ride).
Il tuo stile illustrativo è unico, i tuoi soggetti sono così onirici, e ciò che mi affascina di più è la tecnica: l’uso esclusivo delle matite colorate per creare anche i contrasti tra luce e ombra. Quando hai capito che, prendendo una matita in mano, stavi disegnando il tuo futuro?
M: Quando ho iniziato l’accademia venivo da un paesino di campagna e non avevo i soldi per comprarmi i colori, mentre le matite costavano veramente niente. Io andavo in treno avanti e indietro e non potevo portarmi teli e pennelli; quindi, ho cercato di rifare lo stesso lavoro che facevano gli studenti con olio e colori con le matite, che costavano molto meno. Ho avuto grossi problemi in accademia per queste cose qua ma pian piano ho scoperto che alle persone piaceva di più questa tecnica e l’ho affinata. È quella che mi ha permesso di entrare in un mondo che non mi potevo permettere e non la abbandonerei mai.
L’elemento femminile, la sensualità, la natura e l’onirico sono temi ricorrenti nei tuoi disegni. Trovi ancora ispirazione nel mondo attuale, o lavori più con fantasia e storia?
M: Io ho bisogno di avere un fastidio, sennò non lavoro, magari può arrivare anche da una frase buttata lì a cena. Quando ho una motivazione d’odio, riesco a lavorare molto bene (ride).

Qual è un soggetto o un’immagine che usereste per descrivervi come persone e come artisti?
M: Benjamin, qual è un soggetto che mi rappresenta?
B: Per me, lui è un labirinto. Quando lavori con Marco, devi sempre trovare un modo per ispirarlo al 100%. Perché se è troppo facile, lui dice “lo facciamo dopo”, ma se è qualcosa che solo lui può fare, allora lo fa. Questa immagine di un labirinto dentro un cervello: questo è Marco Mazzoni.
M: Sono felice? No. È vero? Sì (ride).
E cosa sarebbe Benjamin?
M: Penso sia una delle poche persone che, se dice che vuole qualcosa, la ottiene. È una persona da cui prendere spunto, se ti dice ‘ho questo progetto’, lo fa. E all’inizio il progetto sembra impossibile, ma poi lo realizza.
B: È vero, e a volte le idee non funzionano, ma bisogna comunque dare il massimo. Se provi davvero tutto e non funziona, non è un problema. Ma se non hai dato il massimo, finirai per pensare: “E se avessi fatto quella cosa…?”
M: Quando lavori a lungo allo stesso progetto, ci sono dei momenti in cui molli un attimo. Ma lui mi aveva detto all’inizio: “Ricordati che c’è il tuo nome su questo libro, e quello rimane anche tra 10 anni.” E questa cosa, che sei sempre obbligato a dare il meglio, è il riflesso di una persona che spinge al massimo anche gli altri, proprio perché c’è anche il suo nome dentro.
Photos by Luca Ortolani
Thanks to Ippocampo Edizioni





